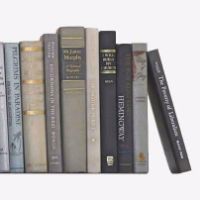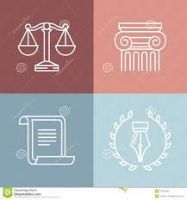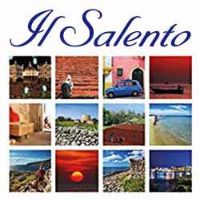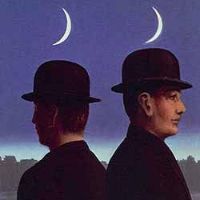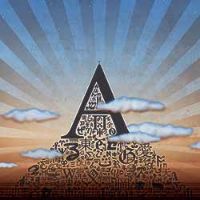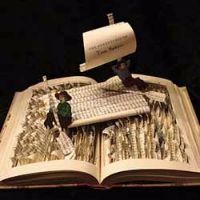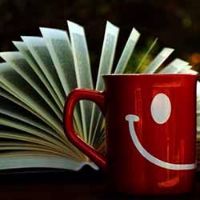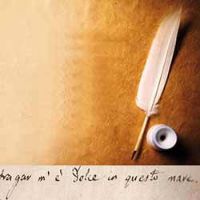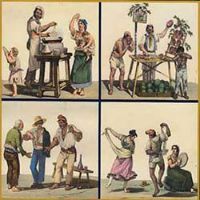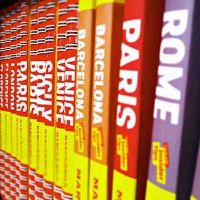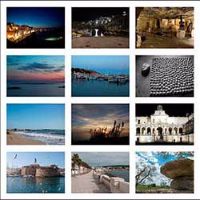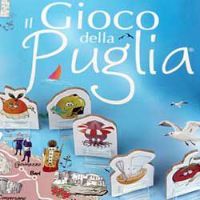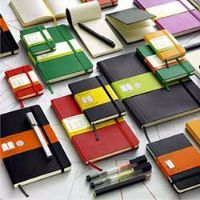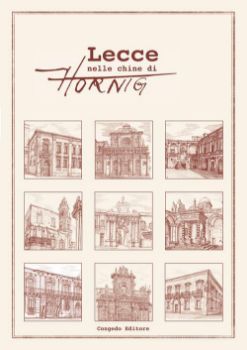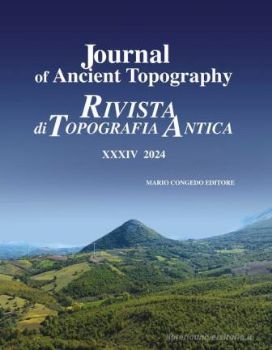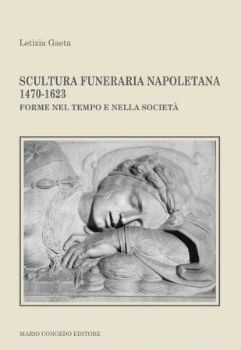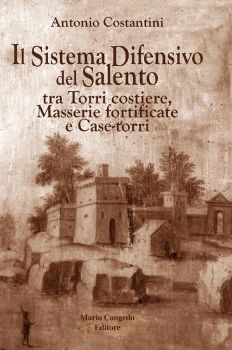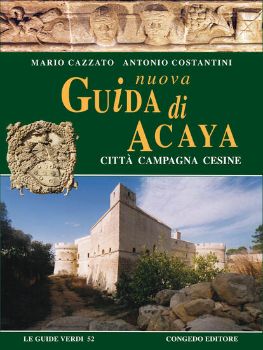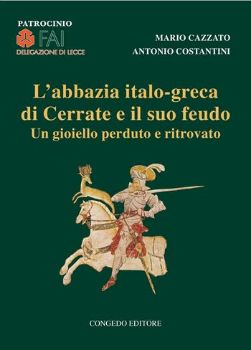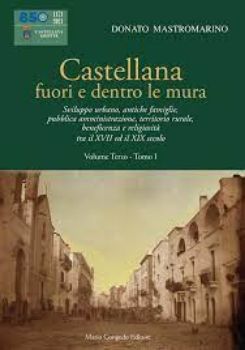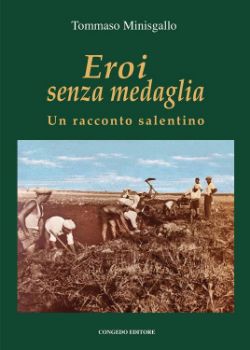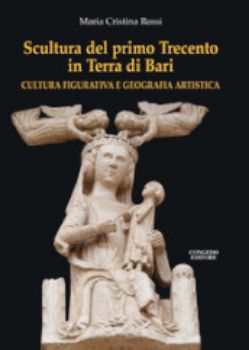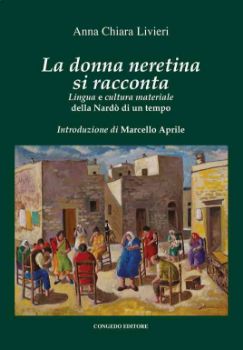Dettagli
| Dati | Descrizione |
|---|---|
| EAN | 9788880860761 |
| Autore | Marti Mario |
| Editore | CONGEDO EDITORE |
| Data pubblicazione | 1994 |
| Categoria | Letteratura & Filosofia, Linguistica & Dialetto |
| Pagine | 488 |
Solo gli utenti registrati possono scrivere recensioni
Dello stesso editore
JOURNAL OF ANCIENT TOPOGRAPHY-RIVISTA DI TOPOGRAFIA ANTICA (2024) - VOLUME 34
Aa.Vv. - Patitucci Uggeri S. (Cur.)
€ 80,00
SISTEMA DIFENSIVO DEL SALENTO TRA TORRI COSTIERE, MASSERIE FORTIFICATE E CASE-TORRI (LE)
Costantini Antonio
€ 50,00
L`ABBAZIA ITALO-GRECA DI CERRATE E IL SUO FEUDO. UN GIOIELLO PERDUTO E RITROVATO (L`)
Cazzato Mario - Costantini Antonio
€ 18,00
SCULTURA DEL PRIMO TRECENTO IN TERRA DI BARI. CULTURA FIGURATIVA E GEOGRAFIA ARTISTICA
Rossi Maria Cristina
€ 25,00
DONNA NERETINA SI RACCONTA. LINGUA E CULTURA MATERIALE DELLA NARDO` DI UN TEMPO (LA)
Livieri Anna Chiara
€ 25,00